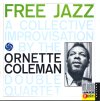
Da "FREE JAZZ" - Ornette Coleman -
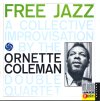
First Take
è una vera scoperta, un brano dimenticato per molto tempo, (pare) da chi l’ha concepito, da chi l’ha suonato e dagli stessi ingegneri del suono. Esso è letteralmente un conciso "primo brano" di Free Jazz (Atlantic 1364) una delle registrazioni più importanti e provocatorie, che negli scorsi quindici anni ebbe una grande influenza. Probabilmente è stato dimenticato a causa dell’inquietudine generata dalla sua versione completa in precedenza registrata. Ma questa, più breve, possiede allo stesso modo delle qualità ed un entusiasmo propri, che la rendono valida di per se stessa.Il progetto per First Take, è lo stesso di Free Jazz; un doppio quartetto. Un breve e libero preludio d’insieme per introdurre i solisti. Gli assoli non sono limitati da strutture pre-arrangiate, cosicché i solisti possono interagire spontaneamente con gli altri musicisti in una specie d'improvvisato contrappunto atonale d’atmosfera.
La libera apertura d’insieme, porta al primo assolo di clarinetto basso eseguito da Eric Dolphy. Qui il fraseggio è libero e più mutante, anche se talvolta troppo "vocale" rispetto a Free Jazz. Da rilevare sono le variazioni nel tempo, e gli eleganti richiami conclusivi nel secondo passaggio d’insieme.
Freddie Hubbard, il solista che segue, mi sembra qui troppo sbottonato e libero, anche se il primo e i successivi contrappunti verso la fine del suo assolo sono una vera meraviglia; quel genere di cose che si vorrebbe riascoltare anche dopo averle udite per la prima volta.
Le figure d’insieme che introducono lo stesso Coleman (come quella successiva che introduce Don Cherry), sembrano fatte su misura per lo stile melodico del sassofonista. Egli stacca con un ritmo medio che contrasta con l’andatura elevata della parte che precede il suo assolo, e va avanti così sino alla fine.
Anche Don Cherry tiene una ritmica simile ma rientra in modo più pacato e meno incisivo.
La linea di contrabbasso contrassegnata dal penetrante virtuosismo di Scott La Faro, predomina su quella più tradizionale e semplice di Charlie Haden, e prosegue dopo il breve passaggio d’insieme guidato dalla tromba, che suddivide la sezione.
In questo brano non sono in grado di classificare i batteristi, ma sono sicuro che ascoltandolo sarete in grado, divertendovi, di farlo voi stessi. (Riuscirete a capire come uno dei due batteristi sta giocando con la ritmica di base e con il tempo sovrapposto dagli assoli di Coleman e di Cherry).
Non credo che First Take riesca a raggiungere l’oscura profondità o gli apici raggianti di Free Jazz, ma proprio per i suoi assoli talvolta liberi da schemi, per le sue nette ed intense sovrapposizioni, lo ritengo un brano speciale e di valore.
Non posso concludere senza ricordare con tristezza che due tra i maggiori musicisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo pezzo, Eric Dolphy e Scott La Faro, sono morti.
MARTIN WILLIAMS
Note tratte dalla versione originale del LP "Free Jazz".
Questa è una registrazione eccezionale, eccezionale sotto molti punti di vista ed è quindi assai difficile trovare un punto da cui iniziare a parlarne. E’ una libera improvvisazione continua con solo poche e brevi sezioni introduttive. Venne eseguita e registrata contemporaneamente, in una volta sola. Nessuno sapeva quanto tempo sarebbe durata; furono semplicemente accesi due registratori e quando Free Jazz terminò, si poté costatare che la sua lunghezza era di 38 minuti, quanto quella di un LP. Non c’era nient’altro da suonare, nessuna ripetizione, e nessun'aggiunta o correzione da fare.
C’è una singolare formazione, un doppio quartetto, composto da due ance, due trombe, due bassi, e due batterie, e c’è pure la struttura del brano. Il fatto è che lo stile di Coleman è così eccezionale da non aver bisogno di essere commentato, ma è certo che esso non è mai stato così evidente e verificabile come in questo brano. Non c’è solo l’improvvisazione quasi totale, spesso collettiva, che coinvolge otto persone a creare con immediatezza. Non ci sono temi preconcetti, né schemi di accordi, né ritornelli stabiliti. Le indicazioni per ogni solista vennero limitate a brevi preludi d’insieme per introdurlo e dargli l’intonazione. Per il resto si trattava di feeling ed immaginazione, di ogni singolo musicista, e del gruppo nel suo insieme. Puntualizza Coleman: "Stavamo esprimendo la nostra fantasia e le nostre emozioni quanto bastava per essere catturate dal registratore".
Coleman affermò che una delle idee di base nella musica consiste nell’incoraggiare chi sta improvvisando ad essere libero e non ad obbedire a modelli melodici preconcetti, in favore di una personale armonia e di una propria tonalità: "Proviamo a suonare la musica e non l’esperienza personale". Il suo punto di vista è tuttavia emotivo ed estetico, non tecnico. La musica dovrebbe essere una diretta ed immediata "espressione della nostra fantasia e della nostra emotività, piuttosto che un retroterra per le emozioni".
I paragoni con la pittura astratta contemporanea e con la musica western di oggi, rendono ciò più evidente. Lo stesso vale se si considerano i venerati schemi della musica occidentale, improvvisazioni basate sulla concordanza tra le tonalità e sulle ritmiche dei singoli musicisti stabilita all’inizio della session.
Spesso l’assolo è qui (come nella maggioranza del New Orleans) uno scambio tra solisti. "La cosa più importante per noi" dice Coleman "fu suonare assieme, nello stesso momento senza ostacolarci, ma anche avendo un proprio spazio discrezionale e soprattutto avendo chiari questi concetti per tutta la durata della registrazione. Quando un solista suonava qualcosa che mi suggeriva un'idea o mi dava un’indicazione, lo seguivo con il sax a modo mio, mentre lui continuava ovviamente libero nel suo assolo". Una specie di accompagnamento musicale polifonico basato sulla tonalità, sulla direzione melodica e quindi su di una forza emotiva.
Ci fu una breve fase preparatoria per quest’incisione, che non vide le persone che avevano già suonato parecchie volte assieme. Coleman e Cherry sono ben abituati alla spontaneità ed alla libera improvvisazione, ed a suonare con loro, i batteristi Ed Blackwell e Billy Higgins, ed il bassista Charlie Haden. Anche Scott La Faro aveva suonato con il quartetto di Coleman, ma egli possedeva, così disse, un profondo ed irremovibile rispetto per l’armonia. Freddy Hubbard aveva suonato con Eric Dolphy, ma Coleman l’aveva sentito improvvisare con Don Cherry. Sentirete che il modo di suonare di Hubbard è in quest’occasione più tradizionale rispetto a quello degli altri solisti. Lo stesso vale per La Faro. Con ciò non intendo fare una critica negativa, né tanto meno voglio dire che questi musicisti abbiano una minore volontà d'improvvisazione. Penso invece che abbiano molto orecchio per l’armonia, e che nella breve introduzione d’insieme non usino solo le tonalità ma le loro armonie e ciò contrasta suggestivamente con gli altri solisti,.
Lo stile di Eric Dolphy è più criptico. (Per inciso, è stato lui a scegliere il clarinetto basso tra le tante ance da lui suonate). Egli ha affermato di esaminare tutte le proprie scelte tonali ed armoniche, e sappiamo che possiede molto orecchio. Solitamente utilizza la struttura armonica ed i ritornelli del brano, ma molto liberamente credo. Anche l’esecuzione stessa è molto libera, e ciò a grande beneficio del risultato, "Per far parlare lo strumento, con maggior o minore forza". (Ad esempio alcune note dell’assolo di Hubbard, portano il clarino di Dolphy ad un gradevole fraseggio di sfondo).
Free Jazz non è un brano a tema con variazioni inteso in senso tradizionale; le parti scritte sono brevi preludi per i solisti, che hanno lo scopo di introdurli e di spingerli nella melodia. I solisti non suonano variazioni sul tema; la loro improvvisazione è la melodia stessa, ed il tema, è ciò che loro stessi inventano al momento. I due bassisti e i due batteristi, suonano per tutto il tempo, direi proprio con brio, seguendo la musica con spontaneità. Ogni fiato ha uno spazio solistico di circa cinque minuti, mentre chi guida la sezione ne ha dieci. Ogni bassista ne ha cinque, mentre i batteristi la metà. Alcuni preludi d’insieme utilizzano gli stessi schemi, anche se talvolta frammentati, orchestrati o intonati diversamente. Altri preludi utilizzano nuovi schemi. Anche Coleman dice che, con una certa spontaneità quasi come un accidente collettivo, una delle introduzioni scritte si dissolve durante l’esecuzione, mentre Blackwell riprende la parte di Hubbard suonata nel preludio. L’insieme, tuttavia, non deve per forza essere pulito, con i fiati che suonano assieme la stessa partitura; essi si lanciano nella stessa tonalità che in alcune parti può sembrare del tutto casuale.
Free Jazz inizia con una breve sequenza polifonica suonata dai fiati, una specie di armonia, o "accordatura emotiva", per poi proseguire nel primo preludio d’insieme. Ciò viene suonato in ciò che Coleman chiama "unisoni armonici", termine fantasioso da lui coniato (e realizzato), che pare privo di senso sino a quando egli stesso non chiarifica che ogni fiato ha una determinata nota da suonare, ma così lontane l’una dall’altra, da produrre un effetto unisonico piuttosto che armonico. Segue quindi l’assolo di Dolphy. Vale la pena notare come, ad un certo punto quando egli raddoppia la ritmica, la risposta della batteria sia immediata. Secondo Coleman, Dolphy dà risposta agli strumenti che lo accompagnano "quasi come se li stesse suonando lui".
Viene poi l’introduzione allo spazio dedicato ad Hubbard. Coleman spiga che "anche questa sequenza è un unisono armonico, ma ad un altro livello". Hubbard inizia accompagnato solo dai contrabbassi e dalle batterie, per poi invitare a suonare anche gli altri fiati che in breve gli danno spinta per poi lasciarlo nuovamente alla sezione ritmica.
Il preludio che presenta Coleman inizia con un graduale insieme di suoni, per poi complicarsi relativamente. Notate come Coleman riprenda per due volte il fraseggio del tema, prima di allontanarsi. La risposta degli altri strumenti alla sua melodia, dà vita ad una delle più complesse strutture del disco. Ascoltando la registrazione, Coleman disse: "Gli altri continuano in una composizione così sublime, che la libertà diventa impersonale".
Il primo lato del disco termina con l’introduzione di Cherry in dissolvenza (artificiale), all’inizio del suo assolo. Il secondo lato inizia nuovamente con un insieme che si caratterizza per "l’unisono trasposto" che introduce Coleman. All’inizio c’è l’accompagnamento del gruppo, poi Cherry è solo con i contrabbassi e le batterie. Poi torna Hubbard con la sua tromba, e quindi Coleman.
L’assolo di Haden è introdotto da una parziale ripetizione dell’armonia d’insieme, mentre la batteria tiene un ritmo sostenuto, ma tranquillo. Haden è qui melodico. Lo segue La Faro su un accompagnamento armonico. Il suo assolo inizia con un’improvvisazione contrastante, immediatamente melodica, sullo stile Django Reinhardt. (Sono tuttavia certo che questo pezzo sia eccezionale per il magnifico lavoro di questi due bassisti presi singolarmente).
Un "unisono armonico" introduce Ed Blackwell. Dice Coleman: "Il suo è un assolo ritmico a tre dimensioni e a tre velocità, oltre che melodico" in una fusione di essenzialità. Higgins segue un successivo preludio con i piatti, con Blackwell che ovviamente gli sta dietro. La tecnica e l’esperienza che sostengono questo splendido modo di suonare la batteria, hanno una base emotiva; "le sue suggestioni liberano il ritmo e la metrica" puntualizza Coleman.
La conclusione è armonica, e come disse Coleman dopo aver ascoltato la registrazione "gli strumenti sembrano delle voci che cantano".
Altri jazzisti hanno prima di loro provato ad improvvisare senza schemi riuscendo a proporre del blues in chiave diversa e soddisfacente. Il contributo di queste persone è di notevole importanza in quanto ha sostenuto una più spontanea nascita di produzioni come questa.
D’altro canto, l’ascoltatore aperto alle novità ed alla differenziazione che commenta questa registrazione dicendo: "è come un pianto, una chiacchiera, una risata" ha una chiara idea della musica di Ornette Coleman.
MARTIN WILLIAMS